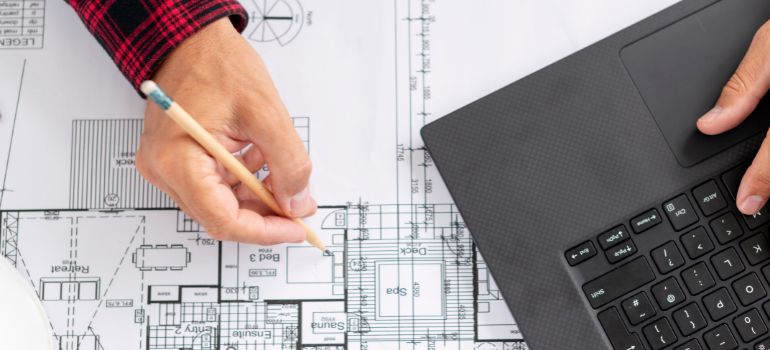Cosa cambia con il nuovo codice degli appalti?
Come cambia la disciplina degli appalti con il Nuovo codice dei contratti pubblici? Scopri nel seguente articolo tutte le novità più significative introdotte dal D.Lgs. 36/2023.

- Il Nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs 36/2023, è entrato in vigore lo scorso 1° luglio, introducendo significative novità.
- L’obiettivo del legislatore era quello di snellire le procedure di affidamento dei contratti pubblici, anche allo scopo di attuare in tempi certi gli obiettivi del PNRR.
- Il nuovo codice incide proprio sulla cornice dei principi che regolano l’affidamento dei contratti pubblici, improntando il regime ai principi di risultato e fiducia.
Il Nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) è stato una delle più significative novità legislative introdotte nel 2023. La riforma cambia proprio quelle che sono le colonne portanti che regolano la procedura di affidamento dei contratti pubblici.
L’obiettivo era proprio quello di mutare la cornice ideologica che regola la materia, passando da un sistema il cui principale obiettivo era quello di tutelare la concorrenza a un sistema ove si tenta di attuare il c.d. principio del risultato, in virtù del quale è necessario realizzare o erogare in modo efficiente e tempestivo l’opera o il servizio.
Nel seguente articolo esamineremo in modo molto approfondito come cambia il nuovo codice dei contratti. In particolare, procederemo ad analizzare il sistema delle fonti, che impiega un innovativo meccanismo di delegificazione.
Dopodiché, tratteremo i nuovi principi che regolano la materia, evidenziando proprio come il Dlgs 36/2023 abbia segnato uno spartiacque tra due epoche, per quel che concerne la disciplina in esame.
Poi ci soffermeremo proprio sulle principali e più significative modifiche apportate dal nuovo codice, per esempio rispetto alle procedure di affidamento e ai criteri di aggiudicazione.
- Nuovo codice appalti: il sistema innovativo delle fonti
- Previgente codice degli appalti
- In vigenza del nuovo codice appalti
- Nuovo codice dei contratti: principi
- Regime dell’affidamento: come cambia?
- Contratti sotto soglia
- Contratti sopra soglia
- Nuovo codice appalti e criteri di aggiudicazione
- Progettazione e appalto integrato
- Appalto integrato: cos’è
- Responsabile unico per il progetto – RUP
Nuovo codice appalti: il sistema innovativo delle fonti
Il Nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) è entrato in vigore lo scorso 1° luglio, introducendo significative novità, anche dal punto di vista del regime delle fonti.
Esso si presenta come un codice auto esecutivo, che presenta molteplici allegati aventi proprio la funzione rendere il codice auto esecutivo, senza la necessità di aspettare l’adozione di norme attuative regolamentari. In tal modo, si sostituisce tutta quella che era la precedente disciplina attuativa.
Il nuovo codice è stato introdotto su impulso dell’Unione europea. Infatti, in sede di trattative per il PNRR, era stato proprio previsto come obiettivo quello di prevedere una nuova disciplina, più snella ed agevole, per facilitare gli affidamenti ed accelerare i tempi di realizzazione di opere e progetti.
Ti consigliamo di approfondire l’argomento leggendo anche: Appalto: cosa vuol dire e come funziona il contratto


Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Previgente codice degli appalti
La precedente disciplina consisteva per un verso nelle disposizioni contenute nel regolamento in materia di contratti pubblici, che pur essendo un regolamento del 2010, attuativo del codice del 2006, era stato, anche dopo il codice del 2016, lasciato in vigore. Poi il codice del 2016 riconosceva una funzione regolatoria molto importante all’ANAC, sul modello seguito per altre autorità indipendenti.
L’ANAC poteva quindi regolare alcuni aspetti attuativi del codice. A tal fine era stata introdotta quella particolare categoria di fonte rappresenta dalle linee guida ANAC.
In vigenza del previgente codice, le linee guida potevano assumere diversa fisionomia:
- alcune venivano recepite con regolamenti governativi;
- altre operavano direttamente ed erano esse stesse fonti di norme.
Potrebbe interessarti anche Decreto Flussi: quali sono le novità 2023
Nell’ambito di questa seconda categoria – ovvero le linee guida non recepite che operavano come fonte autonome – si distingue tra:
- linee guida vincolanti che erano fonti a tutti glie effetti;
- linee guida non vincolanti, che avevano funzione di soft low e servivano a orientare ed indirizzare, anche se non vincolando formalmente, le stazioni appaltanti. Le stazione potevano motivatamente discostarsene, ma poi, nella prassi, il timore di incorrere in responsabilità in caso di inosservanza rendeva di fatto queste linee guida anche esse vincolanti.
Si trattava dunque di un sistema variegato, che si completava con tutta una serie di regolamenti settoriali che andavano a disciplinare particolari settori. C’era una pluralità di regolamenti attuativi: il regolamento generale del codice previgente che in parte rimanga in vigore, le linee guida ANAC differenziate e una serie di regolamenti governativi.
Che ruolo ha l’ANAC nell’ambito dei contratti pubblici? Scoprilo leggendo: ANAC: cos’è e su cosa vigila

In vigenza del nuovo codice appalti
L’attribuzione della funzione regolatoria non esclusiva all’ANAC aveva sollevato perplessità, giacché aveva portato sul piano pratico all’emanazione di molte linee guida, alcune vincolanti, altre no. Questo non agevolava neanche un ordine normativo e la facile conoscibilità della regolamentazione attuativa.
Per questa ragione, già nella legge delega che porterà al nuovo codice dei contratti, vi era l’esigenza di far venir meno la funzione regolatoria, rafforzando le altre funzione di controllo e vigilanza.
Con il D.Lgs 36/2023, il legislatore prevede un meccanismo di delegificazione particolare. O il Consiglio dei ministri o il Ministro, possono adottare regolamenti di identico contenuto agli allegati. L’allegato sostituito, entro tre mesi da regolamento di identico contenuto, viene in questo modo delegificato. L’allegato avrà valore regolamentare così come le successive modifiche possono essere fatte con l’approvazione del regolamento o governativo o ministeriale.
Questi regolamenti sono semplificati, giacché è derogata la disciplina della l. 400/1988 che prevede il procedimento di emanazione dei regolamenti. Essi non sono sottoposti al parere del Consiglio di stato, né alla registrazione della Corte dei conti, e non è neanche richiesto il parere delle commissioni parlamentari che si chiedono per taluni regolamenti.
Quindi, è sufficiente il parere del Consiglio dei ministri. La funzione di questa previsione è proprio quella di mutare la fonte senza modificare il contenuto sostanziale.
LEGGI ANCHE: Contratto di somministrazione: cos’è, quanto dura, vantaggi e svantaggi
Nuovo codice dei contratti: principi
La prima parte del codice – i primi 12 articoli – è dedicata ai principi ed è certamente la meno tecnica. Il codice si apre con tre principi fondamentali – risultato, fiducia e accesso al mercato. Il quarto articolo, per sottolinear l’importanza di questi tre principi, li individua come criterio interpretativo: in pratica, tutte le disposizioni del codice devono essere applicate e interpretate in base a questi principi. In casi dubbi la soluzione da preferire è quella più coerente con il principio del risultato.
Sono principi tra loro differenti: risultato e fiducia sono innovativi ed esprimono la cornice culturale entro la quale il codice si inserisce. Sono principi che hanno funzione soprattutto di indirizzo orientativa.
Come dice il co 1 dell’art. 1, il risultato che il codice si propone è l’affidamento del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo, in quello che è il quadro legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato vuole evidenziare come la tutela della concorrenza non sia il fine ma il mezzo per ottenere il risultato.
La fiducia si collega a questo: parte dal presupposto che l’atteggiamento nei confronti dei soggetti coinvolti nell’affidamento sia di favore. Si presume che le amministrazioni, i funzionari e gli operatori economici operino lealmente, in un rapporto che è di reciproca fiducia. Si abbandona la c.d. logica del sospetto, ossia la presunzione che il funzionario sia corrotto e l’operatore economico sia colluso. C’è la presunzione che essi operino legittimamente.
Ti consigliamo anche di leggere: DURC online: come si scarica per verificare la regolarità contributiva
Regime dell’affidamento: come cambia?
Per quanto riguarda le procedere di affidamento dei contratti, il Nuovo codice appalti prevede, come in passato, la distinzione tra contratti sotto soglia e sopra soglia. Questa è una distinzione introdotta dalla disciplina comunitaria, la quale ha previsto che per i contratti che superano una certa soglia deve essere effettuata la procedura di gara. A tal fine prevede delle direttive che regolano la modalità con cui questa procedura deve essere posta in essere.
Per i sotto soglia, che non sono in realtà disciplinati dalle direttive, vi è discrezionalità della pubblica amministrazione nel decidere se procedere o meno a gara. In realtà, anche per i sotto soglia potrebbe sussistere un onere di gara, quando:
- i contratti sono connotati da interesse trasfrontaliero certo, come stabilito dall’art. 49 TFUE. Questo caso si verifica quando il contratto, per i flussi economici che è in grado di produrre o altre proprie qualità intrinseche (es. deve essere eseguito in un territorio di confine tra più stati), sono in grado di suscitare interesse di operatori economici provenienti da altri Stati membri;
- nell’ipotesi dell’art. 12 Bolkenstein, cioè quando si tratta di autorizzazioni che hanno per oggetto l’affidamento o l’utilizzo di risorse naturali scarse.
Se vuoi approfondire il tema delle concessioni demaniali e della Bolkenstein, ti consigliamo di leggere: Le spiagge sono un bene pubblico o privato?

Contratti sotto soglia
L’art. 50 dice che per contratti i sotto soglia si procede con le seguenti modalità:
- affidamento diretto per lavori fino a 150, anche senza consultazione di più operatori, che è comunque possibile consultare;
- procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori – invito gli operatori che vado ad individuare in base ad indagini di mercati o elenchi, fino a un milione di euro;
- procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori per lavori di importi pari o superiore a un milione di euro.
In questo caso non si invitano 5 ma 10 operatori e come ulteriore caratteristica si prevede un inciso, salva la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria. Questo è l’unico caso in cui, ad un sotto soglia privo di interesse transfrontaliero, si applica la procedura del sopra soglia e dipende da una scelta della PA che non deve essere motivata.
Quindi la regola prevista è affidamento diretto fino a un certo importo, dopo c’è la procedura negoziale senza bando con invito, che però è una procedura non pubblica: l’amministrazione invita un numero di operatori e poi procede, tra questi, ad una valutazione comparativa che diventa una gara. È una gara senza pubblicità: l’affidamento non è una gara.
Sul tema delle concessioni, ti consigliamo di leggere anche: Beni demaniali: cosa sono, tipologie e caratteristiche
Contratti sopra soglia
Se ci spostiamo ai contratti sopra soglia, il legislatore del Nuovo codice dei contratti prevede due tipologie di procedure: entrambe assicurano il principio di evidenza pubblica, ivi compresa la pubblicità, caratterizzato dalla pubblicazione di bando.
Si distingue tra procedure ordinarie, che sarebbero procedura aperta e ristretta, e procedure flessibili, le quali, rispetto alle procedure ordinarie, si caratterizzano per il riconoscimento all’amministrazione di maggiori spazi valutativi.
Si attribuisce alla PA la possibilità di negoziare le offerte e consentire a coloro che hanno presentato offerta, al termine del procedimento di negoziazione, di modificarla, adattandola anche alle esigenze che l’amministrazione committente intende soddisfare.
Ti consigliamo anche di leggere: Project financing: cos’è e come è cambiato
Per quanto riguarda la differenza tra procedura aperta e procedura ristretta:
- nella procedura aperta partecipano coloro che fanno domanda, c’è la classica pubblicazione di un bando e coloro che sono in possesso di requisiti partecipano alla procedura;
- nella procedura ristretta, la PA manifesta l’intenzione di indire la gara pubblica, tramite avviso di indizione, e invita i soggetti che sono interessati, non a presentare un’offerta, ma a chiedere di partecipare alla gara, cioè di essere ammessi a presentare l’offerta. C’è una fase di preselezione degli offerenti, all’esito della quale quelli scelti sono invitati e possono presentare offerta.
Le altre procedure flessibili sono:
- la procedura competitiva con negoziazione;
- il dialogo competitivo;
- il parteneriato per l’innovazione.
La differenza fondamentale è che c’è una fase di negoziazione in tutte e tre, con gli operatori economici, finalizzata ad adeguare l’offerta iniziale a quelle che sono le esigenze della PA. C’è, da questo punto di vista, una maggiore flessibilità che è riconosciuta anche alla stessa amministrazione.

1. Procedura competitiva con negoziazione
La procedura competitiva con negoziazione è una procedura negoziata con bando. Tutti quelli che sono interessati partecipano, poi c’è una negoziazione con gli offerenti e infine c’è la scelta dell’offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – non in base al criterio del prezzo più basso, perché devo andare a valutare in base ad esigenze specifiche da soddisfare, anche la qualità dell’offerta.
LEGGI ANCHE Quali sono i reati contro la Pubblica amministrazione
2. Dialogo competitivo
Il dialogo competitivo si caratterizza per la presenza di una fase di dialogo con gli operatori economici, che precede la formulazione dell’offerta, mentre nelle altre due procedure, si presenta offerta e poi sull’offerta iniziale si fa la negoziazione e si arriva all’offerta finale, ma c’è prima offerta iniziale senza negoziazione.
Nel dialogo competitivo anche prima dell’offerta inizio il dialogo con i vari operatori economici, a cui spiego le esigenze; l’offerta iniziale è già preceduta dalla fase di negoziazione, questa è la differenza del dialogo rispetto alle altre due procedure negoziate.
TI potrebbe anche interessare: Factoring: che cosa è, definizione, esempio
3. Il parteneriato per l’innovazione
Il partenariato per l’innovazione si giustifica laddove l’esigenza che la stazione appaltante deve soddisfare richiede soluzioni che non sono disponibili sul mercato e che presuppongono pertanto una fase, non solo di esecuzione, ma ancor prima di ricerca e sviluppo, di creazione innovativa, di un prodotto o un servizio che sul mercato ancora non c’è.
Nella parte esecutiva ci sono diversi momenti, ovvero:
- la fase di elaborazione di progetto innovativo, che presuppone una fase di ricerca e sviluppo;
- la fase di erogazione del servizio.
LEGGI ANCHE: Frodi fiscali e Superbonus 110%: come funziona la truffa sulla cessione del credito
Nuovo codice appalti e criteri di aggiudicazione
Il Nuovo codice appalti prevede anche qualche cambiamento rispetto ai criteri di aggiudicazione. Per i contratti sotto soglia, i criteri sono quelli del prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa, mentre la scelta è rimessa alla PA.
Per il sopra soglia c’è una preferenza per l’offerta economicamente più vantaggiosa: l’offerta è tale quando prevede il miglior rapporto qualità/prezzo, o anche il miglior rapporto costo/efficacia del progetto, declinato attraverso il costo del ciclo di vita del contratto. Questo è una variante del rapporto qualità prezzo.
I criteri sono contenuti al 107 ss, titolo V, in particolare le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 108 co 1, individua, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o secondo un parametro di comparazione costo/efficacia, quale sia il costo del ciclo di vita ottimale. Quindi, il criterio costo/efficacia è un modo di verificare il rapporto qualità/prezzo.
Poi il legislatore ci dice pure che può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso, come afferma al comma 3, per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni predefinite dal mercato. In questi casi, non ha senso valutare la qualità: si valuta solo il prezzo.
Si fa eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, perché qua c’è il timore che, quando ci sia alta intensità di manodopera, si possa sacrificare la tutela degli lavoratori coinvolti nel processo produttivo. In questo caso, c’è anche il tipo di tutela garantita ai lavoratori tra gli elementi che possono essere inserit tra i criteri per valutare la qualità dell’offerta.
Ti consigliamo anche di leggere: Guardia di Finanza: cosa fa?

Progettazione e appalto integrato
L’istituto dell’appalto integrato era quasi scomparso dal nostro ordinamento, per essere nuovamente rievocato dal nuovo codice dei contratti pubblici. Il tema dell’appalto integrato si correla al tema dei livelli di progettazione delle opere da realizzare.
Il codice si caratterizza, conformemente ad una direttiva della legge delega, per aver ridotto i livelli di progettazione. Prima, infatti, esistevano tre livelli di progettazione:
- progetto di fattibilità,
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
Oggi ci sono solo due livelli, progettazione di fattibilità e tecnico economico ed esecutivo, quello definitivo è assorbito dai due. Dunque, si assiste all’eliminazione di una passaggio di progettazione. Di regola i progetti li fa la stazione appaltante ed affida i lavori da fare all’operatore economico. Questo può avere pro e contro.
Lo svantaggio principale è che il privato realizzi i lavori sulla base del progetto fatto dalla PA. In questo modo, il privato è vincolato ad un progetto fatto da altri e non dà alcun apporto progettuale. C’è il rischio che, se il privato fa il progetto, lo realizzi al fine di massimizzare i profitti, piuttosto che soddisfare l’interesse dell’amministrazione. Poi, certamente, nella fase esecutiva ha un ruolo predominate, che comunque può comportare abusi.
Appalto integrato: cos’è
L’appalto integrato consente alla PA di sfruttare le capacità progettuali dell’operatore, il quale, specie in alcuni casi, sono preziose, soprattutto dove i lavori presentino una componente tecnologica complessa. Il rischio è che ci possa essere il dominio del privato nella fase esecutiva, con aumento dei costi.
Il legislatore ha alla fine scelto di ripristinare l’appalto integrato e l’ha fatto in maniera disinvolta. Inizialmente si pensava di circoscrivere l’appalto integrato ai lavori complessi che trovano precisa definizione in allegato, caratterizzati da una particolare complessità tecnica e tecnologica, dove un apporto progettuale del privato risulta essenziale.
Invece la norma finale è più flessibile, pone meno vincoli e lascia libera la PA di ricorrere all’appalto integrato per qualsiasi tipologie di lavoro, salvo la manutenzione ordinaria, dove l’appalto integrato non avrebbe alcuna utilità.
La norma è prevista all’art. 44, nell’ambito della disciplina della progettazione. Negli appalti relativi a lavori, la stazione appaltante e l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto possa avere per oggetto l’esecuzione di un’opera, progettata sulla base di un progetto di fattibilità realizzato dal privato, previamente approvato.
Si attribuisce, quindi, alla PA ampia scelta, tenendo conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto previsto in origine. L’amministrazione, quindi, affida un’opera, o servizio, che deve essere progettata. Questo, può creare uno scostamento di costo rispetto a quanto previsto: è un rischio che deve essere valutato, il rischio è che il privato sia dominus della fase esecutiva, visto che la progetta lui stesso.
Tale possibilità di scostamento dei costi deve essere valutata dall’amministrazione nella motivazione che adotta quando ricorre all’appalto integrato. Quindi, la PA deve motivare la scelta di fare l’appalto integrato, valorizzando esigenze tecniche, evidenziando la complessità tecnica dell’opera.

Responsabile unico per il progetto – RUP
Con il Nuovo codice dei contratti pubblici, anche il RUP subisce un significativo mutamento. Tale figura sembra evocare il responsabile unico del procedimento, prevista dalla l. 241/1990. Oggi, invece, tale acronimo indica il responsabile unico del progetto, uno figura diversa.
Sono evidenti le differenze rispetto alla figura del responsabile nell’ambito della l. 241. Il responsabile del procedimento nella 241 è l’unità organizzativa e, all’interno dell’unità, la persona ad esso preposta. In materia di appalti, è sempre la persona fisica e non è mai l’ufficio.
L’introduzione del responsabile del progetto nasce dalla consapevolezza che, in sede di aggiudicazione di un contratto, non c’è un unico procedimento. Il RUP si occupa di tutto ciò che va dall’indizione all’esecuzione. Tale operazione non costituisce un unico procedimento, ma si compone di più fasi: programmazione, progettazione, indizione gara, esecuzione.
LEGGI ANCHE Inquinamento acustico: legge, cause e rimedi
Questi non sono subprocedimenti all’interno di un procedimento che sfocia in un provvedimento unitario, ma, a loro volta, sono tutti procedimenti unitari. Parlare di responsabile unico del procedimento, dove c’è una pluralità di procedimenti, che sono finalizzati ad ottenere un risultato e la realizzazione di un progetto, non appariva adeguato alla reale posizione del soggetto.
Oggi si parla proprio nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, che può essere appalto o concessione, da realizzare con contratto: in pratica, la stazione o ente nomina, nell’interesse proprio, un responsabile del progetto che governa l’intervento pubblico.
Come fa un’unica persona ad avere le competenze, la capacità, il tempo e le risorse per occuparsi di tutte queste fasi? Il rischio è che si chieda troppo a quello che è un funzionario della PA. Infatti, la figura del RUP è sempre stata vista con spavento, perché implica l’utilizzo di ampie risorse e, conseguentemente, il rischio di incorrere in forme di responsabilità.
Si dice allora che, fermo restando l’unicità del RUP, stazione ed ente possano prevedere la nomina per ciascuno di questi procedimenti di un responsabile di procedimento, ovvero per la progettazione, per la programmazione, per l’esecuzione e per dell’affidamento. Quindi c’è un responsabile unico del progetto e poi i responsabili per i singoli procedimenti.
All’amministrazione, è comunque attribuita la mera possibilità di nominarli, non è un obbligo. Tuttavia, questo è un importante approdo, perché le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti, fermo restando le responsabilità di controllo e di revisione.
Ti potrebbe interessare anche: Procedimento amministrativo: cos’è, come funziona e quali sono le regole
Nuovo codice appalti – Domande frequenti
Il nuovo codice dei contratti pubblici cambia la cornice normativa e i principi di riferimento della disciplina. Si passa da una disciplina finalizzata alla tutela della concorrenza a una finalizzata a garantire il risultato atteso.
Il nuovo codice appalti reintroduce la categoria dell’appalto integrato, caratterizzato per il fatto che il progetto dell’opera da realizzare è elaborato sia dall’amministrazione sia dal privato.
Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce il responsabile unico del progetto, cioè un soggetto responsabile dell’attività di gara; in un secondo momento, vengono nominati i responsabili per ogni singola fase procedimentale dell’aggiudicazione.

Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere

Altro su Contratti pubblici
Approfondimenti, novità e guide su Contratti pubblici